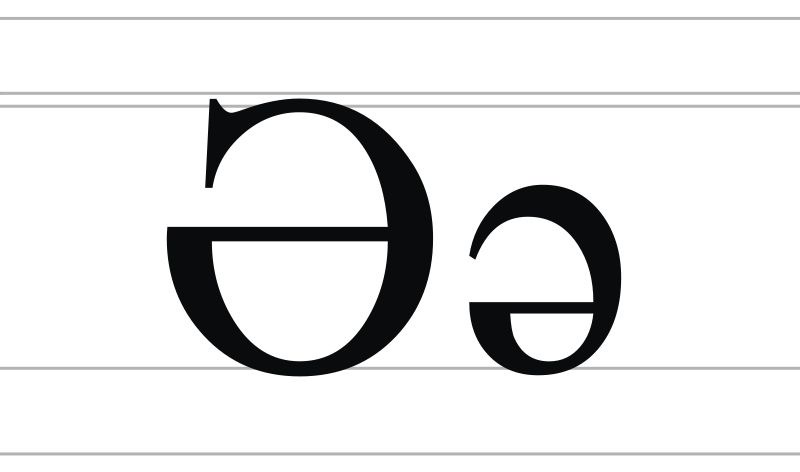Abbiamo intervistato Marwa Mahmoud, consigliera del comune di Reggio Emilia dal 2019, dove presiede una commissione consiliare che si occupa di diritti umani, pari opportunità e relazioni internazionali.
Di quali temi si occupa come consigliera comunale a Reggio Emilia e in qualità di attivista?
Sono stata eletta a presiedere questa commissione all’inizio del mandato e per me è stato un grande onore, perché i diritti umani sono temi su cui mi batto da sempre: i diritti sociali, civili e di cittadinanza. Su quest’ultimo in particolare mi batto da 20 anni perché a 18 anni diventai maggiorenne e avevo grande consapevolezza in merito.
Come ha vissuto il percorso di riconoscimento del suo diritto di cittadinanza?
I miei genitori e mio fratello non avevano la cittadinanza a causa di vari motivi burocratici e legati alla cittadinanza di origine. Io quell’estate andai in vacanza in Egitto, il mio paese d’origine, e chiesi a mio padre di provvedere alla raccolta di tutti i documenti necessari: atto di nascita, casellario giudiziale, la traduzione, la legalizzazione. Passaggi diversi e onerosi. Dai 18 ai 22 anni ho atteso ben quattro anni per la notifica del decreto di acquisizione della cittadinanza italiana. In quei quattro anni in cui divenni studentessa universitaria a Bologna, cominciai a vivere in quel limbo sospeso in cui non sei “né carne e né pesce”, non potevo neanche rivendicare il fatto di essere un lavoratore/lavoratrice come prevede la legge nei confronti dei migranti, che li vuole principalmente come lavoratori per la manodopera. Si fatica ancora oggi a riconoscere che un ragazzo possa nascere e crescere in Italia, essere uno studente/studentessa universitaria, formarsi qui ed essere riconosciuto come cittadino italiano. Io non ho potuto partecipare al programma Erasmus, non ho potuto fare servizio civile regionale e nazionale, non potevo iscrivermi ad una facoltà che a suo tempo prevedeva l’iscrizione all’albo nazionale, non ho potuto votare. Tra tutti il fatto di non poter votare l’ho vissuto come una grande ingiustizia, perché sono stata sempre circondata da amici molto attivi dal punto di vista politico, nel mio ambiente si era formata una coscienza politica, si discuteva di temi politici, ci si confrontava, e il fatto di non avere la cittadinanza italiana, di non aver la tessera elettorale, di non poter votare per me era una grande sofferenza e ingiustizia. Fu in quel periodo che cominciai a vivere sulla mia pelle il peso di questa condizione dipesa da una legge del 1992. Iniziai così a far parte delle prime forme di associazionismo, per poi arrivare al 2015/16 a fondare il Coordinamento Nazionale delle nuove generazioni italiane (CONGI), il movimento degli italiani senza cittadinanza insieme a tantissimi altri attivisti da tutta Italia, figli di migranti.

Com’è stata la sua esperienza di seconda generazione in Italia rispetto a quella migrante dei suoi genitori?
Ho strutturato molto presto la mia consapevolezza rispetto a cosa volesse dire vivere delle discriminazioni. L’intersezionalità oggi è un tema molto popolare nel dibattito pubblico italiano. Io già da giovanissima mi sentivo più vulnerabile e più esposta alle microaggressioni e discriminazioni rispetto alle mie coetanee. In particolare, le pressioni sociali possono diventare ingombranti quando non se ne ha ancora la consapevolezza. Le discriminazioni le ho vissute perché figlia di migranti, perché ero una ragazza di origine araba, di fede mussulmana, e perché sono una donna. Mi accorgevo che le ragazze di origine straniera portano un peso maggiore rispetto ai coetanei, e questo grava al processo transculturale. Così come su tutte le donne insiste il peso sociale del lavoro di cura, questo diventa ancora più gravoso nel percorso migratorio. In tale passaggio tutto ricade molto sulle spalle delle mamme, delle zie, delle nonne e delle figlie. Ci sono grandi aspettative da una parte e dall’altra: da una parte c’è la volontà della propria famiglia a voler tramandare il proprio patrimonio linguistico, culturale e spirituale, per cui cercano di trasmetterteli con grandi aspettative; poi c’è un’altra spinta della società che si vive varcando la soglia di casa, si ha la percezione di non essere mai all’altezza. Lì fuori non sei mai abbastanza italiana, e forse un giorno arrivi a capire che non lo sarai mai. Lo sei solo se vai a soddisfare determinati criteri, standard, indicatori. E allora ti accorgi che non puoi vivere per sempre ingabbiato nell’opinione altrui, non puoi vivere cercando di soddisfare l’una o l’altra parte, ma in quella frontiera ci devi convivere trovando un tuo equilibrio.
Il suo lavoro divulgativo è stato prezioso soprattutto in occasione della tragica morte di Saman Abbas, perché l’ha sentita particolarmente vicina?
Sullo schermo della tv ho visto quelle due foto di Saman Abbas: da una parte una Saman molto coperta in un vestiario che lei non amava indossare, dall’altra una Saman più sorridente e molto più a suo agio con jeans, t-shirt, rossetto. Era a suo agio perché quello era il suo modo di viversi la libertà. Mi sono rivista nella conflittualità identitaria che si vive quando si è a ridosso di un confine. Quella ragazza viveva una grande lacerazione, non è stata compresa, non c’è stato il supporto e il sostegno che avrebbe dovuto salvarla. La sua prossimità culturale e geografica qui a Novellara in provincia di Reggio Emilia, il suo essere duplice e l’assurdità con cui si è consumato un becero femminicidio qui dalle mie parti, non poteva che spingermi a reagire e a scuotere il dibattito politico.
Ancora oggi ci sono molte spaccature nel movimento femminista. Alcuni femminismi fanno a meno dell’importante valore dell’intersezionalità imponendo un modello unico culturale occidentale. Da dove nasce questo errore?
Penso che si pecchi molto quando si fa un parallelismo tra i Paesi e le battaglie politiche e sociali. Va bene dire: “altrove è stata varata questa riforma e rispetto a questo tema sono avanti, dovremmo capire come provare ad essere come loro o provare almeno a capire come questo può essere adattato al nostro contesto”. Invece è pericoloso fare parallelismi scivolosi tra diversi Paesi di origine di alcune comunità di migranti in Italia, e utilizzarli come termine di paragone negativi per dare l’idea che nella migrazione ci sia un’evoluzione anche culturale, che queste comunità partano da una arretratezza culturale e arrivando qua trovano l’occidente e trovano la civiltà. È pericoloso per la costruzione non della convivenza ma della coesione, dell’inclusione delle diversità nel nostro territorio perché crea una scala di valori rispetto alla quale sono collocati Paesi, comunità, origini. Lo si fa con le lingue, i cibi, le religioni. Ogni volta che si parla di femminismi e di violenza sulle donne si finisce per fare questo errore che altro non fa che spostare il baricentro del problema: in Italia, come nella maggior parte dei paesi del mondo, si vive in una società dove il patriarcato vige e prolifera. Questi schemi sociali sono perpetuati e legittimati ovunque.