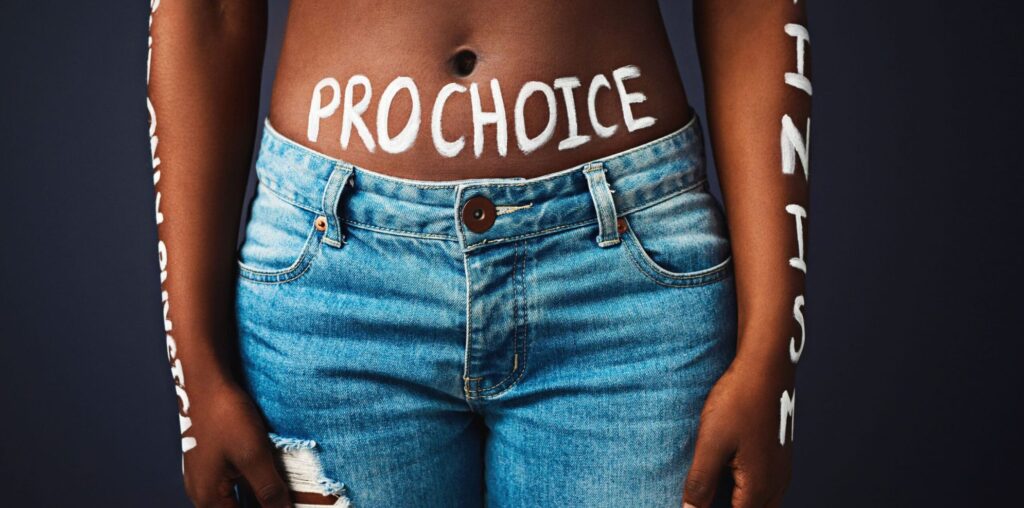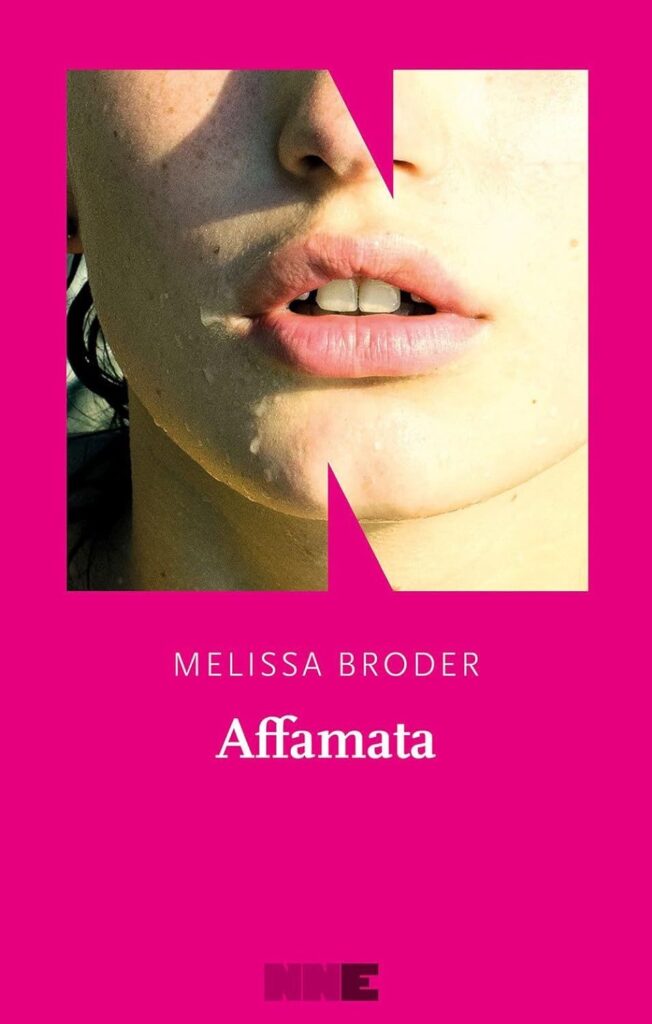Oggi vorrei raccontare con sincerità, ma ancora con grande turbamento, la storia legata a una mia personale esperienza lavorativa, che purtroppo si è rivelata sconvolgente e negativa. Sono sicura che di situazioni come la mia, nonché di peggiori, ne esistano a bizzeffe e questo è un problema grave, di cui è giusto parlare. Si dice sempre che noi giovani non vogliamo lavorare, ma ci si dimentica dell’esistenza alla base di situazioni lavorative malsane. Semplicemente oggi c’è chi per fortuna ha più consapevolezza e riesce a riconoscerle e declinarle.

Ho lavorato per alcuni mesi nel weekend come cameriera e banchista in un bar di una grande città del centro-nord. Per privacy non specificherò il nome. All’inizio, appena assunta, mi sembrava di trovarmi in un luogo ben normato e organizzato. Ero stata messa apposto da un contratto part-time e la paga si aggirava sugli otto euro all’ora. Rispetto ad altri lavori svolti in precedenza, questo per me rappresentava un salto di qualità notevole. Vengo infatti da una cittadina del Sud Italia in cui a parità di lavoro e di ore, la paga era meno che dimezzata, il contratto part-time non era nemmeno lontanamente concepito e l’ambiente lavorativo era sempre gestito da uomini-capi di mezza età spesso burberi, scontenti, aggressivi e sfruttatori.
In confronto, una realtà lavorativa apparentemente sana, il che dovrebbe essere normale, mi appariva invece come un gran colpo di fortuna. Anche qui il mio capo era un uomo, molto giovane, ma burbero e imperativo allo stesso modo degli altri capi che ho avuto. Mi consolavo, però, pensando che lui metteva tutti e tutte apposto e anche i miei colleghi e colleghe continuavano a ripetermi che il capo pretendeva tanto, ma restituiva allo stesso modo se non di più in termini di paga. Per di più lui dirigeva tutto dall’esterno. Faceva ogni tanto capolino nel locale, ma per il resto non lo si vedeva né lo si sentiva, se non nel periodo del mese in cui doveva mandarti lo stipendio. Noi, quindi, dovevamo avere a che fare con il direttore, anche lui un uomo, che però a me sembrava un gran simpaticone, molto affabile, gentile. Una persona a modo che ti faceva notare dove sbagliavi ma sempre con garbo ed educazione.
Ed era vero, il direttore era tutto questo ed era anche un grande amico del capo. Mi parlava spesso di lui, rappresentandolo come un uomo severo, ma giusto, rispettabile e rispettoso. Io, non avendoci quasi mai a che fare, dato che ero l’ultima arrivata e anche quella che lì dentro lavorava meno giorni, mi basavo moltissimo sui suoi racconti. Così iniziai a tenere conto molto di più dell’immagine del capo che lui aveva contribuito a creare per me, piuttosto che sulla prima diretta impressione che io avevo avuto di lui, quella di un uomo severo, ma poco umile e facilmente irrascibile.
Per il resto però le prime settimane di lavoro sembravano filare lisce. I turni erano bene o male rispettati, il personale c’era, io mi trovavo personalmente e lavorativamente bene con tutti i colleghi e le colleghe. Automaticamente la mia testa scacciò via tutti i dubbi e pensieri sul carattere del capo. Finché sul finire di maggio, dopo circa due mesi lì, arrivai un giorno a lavoro per scoprire che il giorno prima più della metà del personale era stato cacciato via. Eravamo rimasti in tre.
Nei giorni successivi le spiegazioni date dal mio direttore furono diverse, ma tutte convergevano verso lo stesso tipo di narrazione: loro si erano comportati male. L’hanno portato all’esasperazione e lui si è visto costretto a licenziare tutti e quattro. Per quanto riguarda i fatti, avevo saputo che due dei dipendenti avevano litigato tra loro e un’altra era intervenuta perentoriamente per risolvere la situazione, cacciando uno dei due che si era comportato male. Quando il capo l’aveva saputo si era arrabbiato e aveva cacciato tutti e tre, più un’altra ragazza che lavorava lì da tempo. In quel caso il direttore mi disse che potevo considerarmi una sopravvissuta, anche perché per loro lavoravo bene.
Molte volte aggiungeva che era davvero un peccato che io studiassi e che, fosse stato per lui, lì avrei trovato il lavoro della mia vita. Il capo per di più mi chiese tramite il direttore se non fossi interessata a fare più turni, ma, dato gli impegni universitari, declinai. Tutti quei complimenti e quelle lusinghe mi facevano sentire speciale, esime da qualsiasi problematica. Mi sentivo dotata di un plusvalore di cui ero meritevolmente detentrice insieme ai pochi altri rimasti. Tutto ciò allontanò anche tutti i dubbi che in un primo momento erano sorti in me subito dopo quel licenziamento di massa sulla gestione del personale da parte del proprietario. Erano riusciti ad ammaliarmi, a raggirare il mio spirito critico, accarezzando il mio ego e io, più lusingata che risentita, non me ne accorgevo.
Senza che me ne rendessi conto però, nonostante non avessi dato la disponibilità per fare più turni, gli orari di lavoro si allungarono terribilmente. Dei quattro licenziati, si rimpiazzarono solo due e fu così che iniziai a passare nove, dieci, undici, a volte anche dodici o tredici ore là dentro perché, finito il turno, non c’era nessuno a sostituirmi, ma la gente andava fatta accomodare lo stesso. Sapevo sempre quando arrivavo e mai quando sarei andata via. Tra l’altro con l’arrivo di giugno, terminarono le lezioni in università. Pertanto diedi anche la disponibilità per un giorno di lavoro in più, dato che loro avevano bisogno di aiuto e io così facendo mi rendevo utile e indispensabile. Mi dicevo che per fortuna le ore in più erano pagate e quel pensiero mi aiutava a sopportare la stanchezza fisica che si andava accumulando.
Quell’ammontare di ore di lavoro infinite tra l’altro rappresentava una situazione normalizzata. Tutti ne facevano tante e alcuni di loro mi facevano sentire terribilmente in colpa se mi ribellavo o sottraevo e allo stesso tempo una privilegiata, perché lavoravo meno giorni. Parlando inoltre con due miei colleghi, un ragazzo dell’est-asiatico, cameriere come me, e un uomo del Bangladesh, lavapiatti, scoprii che loro due, che lavoravano full time, spesso anche senza la giornata di riposo, avevano lo stesso tipo di contratto part-time che avevo io. Mi sentii molto in pena per loro. Per l’ennesima volta mi ripetetti che ero fortunata ad avere un contratto part-time a lavorare effettivamente da tale (più o meno).
Il direttore era molto bravo a presentare quella situazione di illegalità come una causa umanitaria a cui tutti noi sopravvissuti dovevamo votarci per mandare avanti il locale. E questo continuava a coprire la nefandezza del capo, che tra l’altro iniziò anche a lamentarsi del fatto di dover pagare così tante ore in più, come se fossimo noi a volerle fare. Però almeno continuava a pagare. E ripeto, quest’atto di legalità, unito al mio bisogno di soldi, contribuiva dentro di me a giustificare l’intera situazione che andava sempre più precipitando.
Dalla fine di giugno mi fu data anche una nuova mansione, presentatami come un’opportunità di crescita, nonché un atto di fiducia nei miei confronti. Il direttore mi insegnò a usare il registratore di cassa e questo comportò anche che potessi gestire la contabilità e fare l’apertura del locale. Si trattava in realtà di una responsabilità che non avevo chiesto e che non comportava nessun aumento di stipendio, ma che, come succedeva ormai da mesi, accettai perché mi gratificava.
Oggi penso in realtà che il direttore usasse tutti quegli stratagemmi per dividere un po’ con noi il peso che il capo addossava ogni giorno su di lui. Passando molto più tempo lì dentro con lui, infatti, iniziai a notare quanti nuovi incarichi dovesse eseguire per conto del capo che chattava costantemente con lui al telefono e si inventava novità e cambiamenti ogni settimana. Pretendeva che lui e poi tutti noi dovessimo stare dietro ai suoi cambi di idee nel bel mezzo del servizio. Cambiavano infatti spesso i menu, la disposizione del locale e la sua organizzazione, il modo di tenere il banco, le pietanze che offrivamo, a volte i prezzi per gli stessi prodotti e per lui tutto ciò doveva essere eseguito in modo veloce, naturale, senza esitazione. Il direttore s’affannava per star dietro alle sue richieste e noi al seguito arrancavamo.
In quel mese tra l’altro iniziò a presentarsi direttamente lui in persona quasi ogni giorno. Ci rimproverava, ci dava ordini, non riusciva a comunicare con noi alla pari, ma nemmeno come il giusto e buono superiore che tutti mi avevano raccontato essere. Quelle poche volte che ci aveva rivolto un sorriso o una battuta era perché avevamo incassato particolarmente bene quel giorno o quello prima. Una volta, dopo dodici ore di lavoro e dopo aver servito tutti i tavoli a cena, il direttore gli domandò se potessi andar via. Lui rispose con una domanda: “Lavora domani?”. “Sì e fa anche apertura”. Così mi concesse il permesso. Mi chiedo ancora quale sarebbe stata la sua risposta se il giorno dopo non avessi lavorato. Non c’è bisogno di una fervida immaginazione per capirla.
Quel mese inoltre gli incassi cominciarono a calare. C’era un caldo afoso durante il giorno, la gente nelle ore di punta usciva meno e si concentrava soprattutto verso il tardo pomeriggio e la sera. Il capo, più incazzato del solito, se la prese con noi. Un pomeriggio, sempre nel bel mezzo del servizio, urlò con tutta la voce che aveva in corpo contro noi camerieri che non sapevamo fare il nostro lavoro, che non eravamo camerieri veri, che non sapevamo vendere. La minaccia divenne frequente: dovevamo vendere di più o ci avrebbe abbassato lo stipendio. Il nostro turno era finito, mai lui ci intimo “per punizione” di rimanere lì fino al suo ritorno.
Tornò più di un’ora dopo, più calmo, parlandoci più umanamente. Ci disse che in realtà gli piacevamo perché eravamo gentili e veloci ma ci ribadì che dovevamo vendere. Accettavo la critica. Se ci avesse parlato direttamente così fin dall’inizio piuttosto che screditarci davanti ai suoi stessi clienti forse sarebbe stato più efficace anche per lui. Eppure avevamo sempre usato lo stesso metodo di approccio col cliente e fino a quel momento gli incassi si erano mantenuti buoni. Che il calo potesse dipendere da altre ragioni, però, a lui non passava neanche per l’anticamera del cervello.
Divenne sempre più brusco, sempre più maniacale, sempre lì a controllare. Il direttore parlando con me continuava a dipingerlo come un santo, una vittima dei problemi che tutti noi, chi più chi meno, gli creavamo, nonché dello Stato. Allora perché ci tiene tutti ancora qua? Perché non ci licenzia come ha fatto con gli altri a maggio? Sorprendentemente lo stesso direttore tentò di licenziarsi, troppo stanco e oberato dal carico di lavoro micidiale. Passava lì dentro fino a sedici ore al giorno, aveva i piedi che sanguinavano e l’ottimo stipendio non bastava più a tamponare. Ma il capo rifiutò le dimissioni, riuscì a raggirare la sua richiesta, promettendogli di fargli fare meno ore.
Questo a discapito di Alessandra, la banchista, l’unica in grado di gestire quel pandemonio, di cucinare, impiattare e servire drink nel caos di quel banco troppo piccolo ma micidiale. Lei si sentiva speciale per essere in grado di farlo. Era una delle alunne predilette del capo perché gli portava sempre il compitino pronto, a discapito della sua salute fisica e mentale e della sua vita privata. Anche lei come il direttore e anche di più praticamente viveva là dentro.
Sul finire del mese l’aria era diventata irrespirabile. Un giorno il capo indisse una riunione per il giorno stesso alle 16. Noi eravamo lì dalle 12. Chiudemmo il locale e ci spostammo nell’altro bar di sua proprietà, dove si sarebbe tenuta la riunione anche con gli altri dipendenti. Ci riunimmo tutti in uno stanzino minuscolo, eravamo più di dieci. Lì il proprietario, postosi in una posizione centrale ma comunque tenendoci tutti bene a vista come imputati, cominciò la sua litania. Vidi definitivamente cadere la maschera e lui rivelarsi quello che avevo percepito fin dall’inizio. Urlò sguaiatamente contro di noi, incolpandoci del calo degli incassi. Poi prese ad elencare per ognuno di noi cosa avevamo fatto di sbagliato. Alcuni motivi erano futilissimi e di nessuna importanza.
A me per esempio ebbe l’ardire di rinfacciare che mi fossi tagliata il dito sul bancone e che fossi mancata per due ore da lavoro per andare in pronto soccorso, costringendo lui a sostituirmi al locale, per giunta di domenica. Mi disse che gli dovevo mille euro di danni. Io a lui per essermi tagliata il dito e non il contrario. Gonfio e rosso di rabbia, lo vidi afferrare con tutta la forza che aveva in corpo una cassa di birre in vetro sotto di lui e scagliarla rabbiosamente contro la parete. Volarono birra e pezzi di vetro dappertutto. Per fortuna io fui travolta “solo” dalla birra, ma al direttore e a un cameriere arrivarono i vetri che fecero loro dei tagli sulle braccia e sulle gambe. Lui stesso fu colpito da un vetro, conficcatosi nel dito del piede, ma pareva non essersene accorto, fagocitato dall’impeto della sua stessa rabbia. Eravamo tutti stretti e spaventati contro le pareti. Ricordo le facce sconvolte, nessuno che osava fiatare.
Uno dei ragazzi approfittò della situazione per licenziarsi e lui lo cacciò via malamente, sbraitando. Lo stesso fece in un altro scatto di rabbia con il lavapiatti, definendolo l’unico “bangladino” in tuttala città che non era in grado di farlo. Come se saper lavare i piatti fosse una competenza connaturata nel DNA dei bengalesi. Rincorrendolo, lo fece scappar via. Chiese ai rimasti se ci fosse qualcun’altro che voleva licenziarsi. Fui tentata di alzare la mano, ma allo stesso tempo avevo troppa paura di essere rincorsa e cacciata via malamente come l’altro. Perciò in un primo momento stetti zitta. Alle 18 rimandò noi sopravvissuti tra i sopravvissuti a riaprire il nostro locale, come se stessimo iniziando in quel momento la giornata lavorativa e non fossimo là dalle 12. Arrivati però al locale anche il direttore tornò indietro e si licenziò.
Eravamo rimaste solo io e Alessandra, ma il capo al telefono continuava a pretendere che riaprissimo anche se solo in due. Allora lo chiamai per spiegargli che non ce la facevo per quel giorno, ma che potevo rimanere per gli altri, ancora assuefatta e impaurita all’idea del licenziamento. Quando gli spiegai che ero troppo scossa da ciò che era successo per riprendere a lavorare, lui mi disse che non avevo capito niente. E mi mise davanti a una scelta: o riaprivo quel giorno o me ne andavo. Così, inspiegabilmente tra i singhiozzi, scelsi di andarmene. Lui per tutta risposta mi disse: “Bene, meglio così. Non mi servono i bambini che piangono”. Non ho mai ricevuto scuse per il trattamento, per lui era normale, ero l’ultima ruota del carro.
Oggi sono felice di essere una bambina che piange piuttosto che un uomo che usa violenza, ma quel giorno ero devastata perché avevo perso il lavoro e per di più in quel modo barbaro, senza umanità. E nemmeno senza logica. Quando gli scrissi giorni dopo per chiedergli come muovermi per le dimissioni lui mi rispose gradasso e incurante: “Non sarebbe meglio tornare a lavorare piuttosto che chiedermi le dimissioni?”.
La parte più assurda però è un’altra. Quando due mesi dopo sono tornata nel fantomatico bar per intascare l’ultima busta paga, mi era sembrato strano dovermi recare lì di persona, dato che tutte quante le altre le avevo ricevute per bonifico. Il capo non c’era. Ad accogliermi con estrema riverenza ho trovato Ester che ha sempre lavorato lì e, per mia sorpresa, anche il direttore che era tornato, ma in veste di semplice dipendente. Lui mi ha esposto con freddezza che adesso faceva un orario di lavoro “normale”. Dopo aver firmato le ultime carte, lei me l’ha buttata lì: “Non è che vorresti venire a fare due turni il sabato e la domenica mattina qui per far riposare noi?”. Io sbigottita le ho detto che non mi aspettavo quella proposta e che avevo bisogno di pensarci.
In realtà adesso riconoscevo bene quel fare ammaliante che mi aveva catturata precedentemente, rivelato dal porre l’accento su quel “far riposare noi”. Fallo per noi, ne abbiamo bisogno. Come se dovessi fare come sempre un’opera di bene. Quando le ho fatto notare, però, che ero ancora scossa dai turni di lavori inumani e soprattutto dalla violenza del proprietario all’ultima riunione lei mi ha risposto: “Sì hai ragione, non voglio giustificarlo, però sappi che io lavoro qui da otto anni e, credimi, ne ho viste di peggio. Lui fa così, ma poi gli passa. Ne è consapevole, per questo oggi ha detto a me di parlarti. In realtà dentro lui è un orso buono”. Ancora una volta lo stesso meccanismo viscido e affabulatore. Io potevo avere il privilegio di dire di no per fortuna, ma magari qualcun’altro al mio posto, senza la stessa possibilità, probabilmente si sarebbe sentito costretto ad accettare.
Un uomo, a maggior ragione consapevole della violenza reiterata che sta operando, non è un orso buono, ma un uomo violento. Gli orsi stanno nelle foreste, non sono datori di lavoro in posizioni di potere. E se sono buoni non tirano all’aria una cassa di birre, sapendo di poter ferire e spaventare i propri dipendenti. Situazioni come questa sono sicura purtroppo siano molto comuni. E’ un problema sistemico, per questo penso che, per quanto doloro, sia utile condividere queste storie. Smettiamola di giustificare la violenza in qualsiasi contesto, anche in quello lavorativo, altrimenti non la fermeremo mai. Soprattutto iniziamo a chiamarla col suo nome. E iniziamo a chiamare con il nome giusto gli uomini violenti che la operano.